Giovanni Verga: «E che faremo quando saremo ricchi?»
Giovanni Verga (Vizzini, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio 1922), scrittore catanese, vive la realtà italiana del secondo Ottocento, quella che è figlia dell’Unità politica ma anche della Divisione economica: il Nord prospera nella sua incessante tendenza alla rincorsa del progresso industriale; il Sud si fa forte della propria identità indistruttibilmente paesana, orgogliosamente locale.
Ma la tematica del lavoro negli scritti di Giovanni Verga collega le due metà d’Italia, le unisce in un’unica narrazione sociale che attraversa la penisola: l’autore affronta le questioni lavorative in chiave progressista, dove il lavoro e l’attivismo sono la più viva sorgente di ricchezza e successo individuale; ma, allo stesso tempo, ci offre un quadro dello sfruttamento che macchia con miseria e povertà l’economia italiana.
Come ha sostenuto il critico letterario Asor Rosa, Verga appare come un convincente rappresentatore del mondo popolare ottocentesco, dove il «rifiuto di una ideologia progressista costituisce la fonte, non il limite della riuscita verghiana».
 È da questa considerazione che viene valorizzato il passaggio da una fase di narrazione borghese, del lusso e della ricchezza mondani, a una narrativa della campagna, del paese, della comunità (siciliana) che fatica a sostenere la prepotenza e sopraffazione delle classi socialmente superiori. Verga osserva, indaga con oggettività scientifica il suo presente, la realtà tutta, i sobborghi, le cave, i tetti e le stanze delle case. Verga mette luce sui vinti, gli sconfitti di quella società che non permette alla conservazione dei valori tradizionali e arcaici di avere un rispettoso ruolo nell’industrializzata mentalità italiana.
È da questa considerazione che viene valorizzato il passaggio da una fase di narrazione borghese, del lusso e della ricchezza mondani, a una narrativa della campagna, del paese, della comunità (siciliana) che fatica a sostenere la prepotenza e sopraffazione delle classi socialmente superiori. Verga osserva, indaga con oggettività scientifica il suo presente, la realtà tutta, i sobborghi, le cave, i tetti e le stanze delle case. Verga mette luce sui vinti, gli sconfitti di quella società che non permette alla conservazione dei valori tradizionali e arcaici di avere un rispettoso ruolo nell’industrializzata mentalità italiana.
Si nota l’attaccamento alla terra di un padron ‘Ntoni che nei Malavoglia pronuncia un «Va’, va’ a starci tu in città. Per me io voglio morire dove sono nato», un uomo che non mira alla scalata sociale ma gode della sua difficile esistenza ad Aci Trezza. Sì, perché al di fuori del paese c’è la non-esistenza (alienazione, potremmo dire). E questo contrasta con quella gente che vuole accumulare averi, vuole il cambiamento economico, la lotta classista (inter e intra-classista) per poter emergere in una competizione che si autoalimenta.
Sfide e rivalità fanno l’uomo moderno, quello economico. Il Dio Denaro culla i propri figli se obbedienti; chi resta, invece, fedele alla tradizione non ha spazio tra le sue grazie e viene lasciato in preda all’amara sorte che spetta a chi non sta al passo dell’evoluzione.
«Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo […]», dichiara Verga nella prefazione ai Malavoglia diretta all’editore Treves nel 1881. L’obiettivo dello scrittore simbolo del verismo italiano è estraniarsi dalla «fiumana» dell’attività umana per guardarsi intorno e interessarsi ai deboli, ai fiacchi, ai vinti, ai disperati (termini da Verga adoperati nella stessa prefazione) sottomessi ai «sopravvegnenti, vincitori d’oggi […] e che saranno sorpassati domani». È così che Verga è arrivato a osservare per noi un Rosso Malpelo, ragazzino lavoratore, «brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico», solitario ed estraneo a tutti, che sulla propria pelle ha potuto testare con coscienza la coercizione e la brutalità che dominano i rapporti umani, nonché la macabra goduria del tiranneggiamento.
La fede e la lealtà verso il lavoro però restano uno dei temi cardine nelle pagine verghiane: la dignità, la staticità e l’operosità del popolo osservato da Verga sono condizioni esistenziali, collante di quella comunità e collettività che è indispensabile per la ricchezza d’animo – a differenza della prosperità monetaria che porta al solipsismo e all’arida individualità.
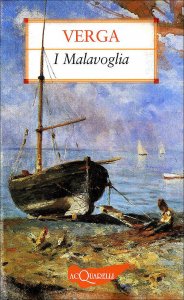 La logica lavorativa della borghese società italiana che si evince, invece, dalla descrizione dell’Italia di fine Ottocento sembra più orientata in un’ottica della singolarità che, attraverso lo sfruttamento della pluralità, si erge dal suo lussuoso e mondano appartamento cittadino. Una neonata nazione che mira all’accumulo della “roba” (termine tutto verghiano da La roba, testo pubblicato nel 1882 in Novelle rusticane), portando l’uomo alla perdita dei valori generazionali, caduti nel dimenticatoio per far spazio ai nuovi ideali del progresso.
La logica lavorativa della borghese società italiana che si evince, invece, dalla descrizione dell’Italia di fine Ottocento sembra più orientata in un’ottica della singolarità che, attraverso lo sfruttamento della pluralità, si erge dal suo lussuoso e mondano appartamento cittadino. Una neonata nazione che mira all’accumulo della “roba” (termine tutto verghiano da La roba, testo pubblicato nel 1882 in Novelle rusticane), portando l’uomo alla perdita dei valori generazionali, caduti nel dimenticatoio per far spazio ai nuovi ideali del progresso.
Perché, in fondo, «viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la esuberanza di tal vita». Almeno, così disse Verga nel 1873. E noi cosa diremmo invece oggi?
Sabrina Pessina per MIfacciodiCultura
Sabrina Pessina
Articoli correlati
Ti racconto Marcel Proust
Cerca un articolo
Seguici su Facebook
Let’s Feel Good
“LET’S Feel Good”: uno show-room culturale dove “sentirsi bene”.
Un luogo dove degustare Cultura, Arte, Intrattenimento: corsi di comunicazione creativa, workshop, incontri con artisti, scrittori e giornalisti, reading letterari e teatrali, serate musicali e aperitivi culturali con degustazioni di vino biologico e birra artigianale.
Un luogo dove sentirsi a casa, immersi in una dimensione artistica che riesce a stupirti comunicandoti sempre qualcosa di nuovo.


Viale Bezzi, 73 – 20146 – Milano
P. IVA 07988450966






